POGGIBONSI |
|

Racconta il Vasari che Giuliano da Sangallo, dopo
l'assedio di Castellina in Chianti del 1478, ed aver effettuato alcuni lavori
alla rocca di Ostia, almeno dal 1488 lavora, su commissione di Lorenzo de'
Medici, alle fortificazioni di Poggio Imperiale. Pur con un'interruzione dovuta
alla morte di Lorenzo, i Sangallo vi operano ancora dopo il 1503, impiegando il
lavoro dei prigionieri pisani, ed i lavori pare abbiano termine nel 1511
lasciando l'opera incompiuta.
Il lungo periodo di gestazione, più che ventennale,
è confermato puntualmente dall'evoluzione tipologica riscontrabile nelle
strutture. Fin dall'origine, però, l'opera del grande progettista, e del
fratello Antonio il Vecchio, aggiungiamo, si dimostra anticipatrice. La
planimetria, infatti, è certamente impostata all'inizio dell'opera e
probabilmente costituisce il primo esempio di architettura bastionata
riscontrabile sul terreno.
Le fortificazioni
sono incompiute: nelle mura della cittadina si interrompono in quota alla fine
della scarpa e nel perimetro a forse i due terzi, mentre la fortezza è completa
nel perimetro, ma potrebbe essere stata portata a termine in quota e poi ridotta
allo stato presente dall'incuria e dal tempo.
L'immagine è di www.politeama.biz |
|
|
|
|
|
|
|
|
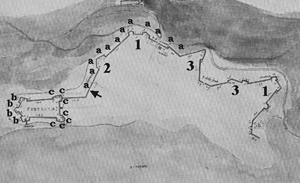 |
La cinta delle
mura non è giunta a chiudere il perimetro della cittadina. I bastioni nelle
posizioni marcate "1" sono di minori dimensioni e pertanto da ritenere
tra i primi costruiti. Il bastione "2" presenta già un aumento
dimensionale e si potrebbe ritenere successivo. Le soluzioni geometriche
presenti nelle posizioni "3" sono estremamente evolute e dovrebbero
essere le ultime realizzate. |
 |
Il tratto di
mura edificato giunge solo alla sommità della scarpa. La punta dei bastioni è a
spigolo vivo ed i fianchi sono rettilinei, mentre quelli di Civitacastellana,
Pisa, Livorno, Arezzo e Nettuno presentano quasi sempre punta arrotondata ed
orecchioni raccordati alla cortina con un tratto curvilineo. Sembra quindi che i
Sangallo abbiano introdotto queste caratteristiche in un secondo tempo e che
l'evoluzione successiva abbia recuperato la loro configurazione originaria. |
 |
L'interno
dell'androne di una porta della cinta muraria mostra l'azionamento del ponte
levatoio a bolzoni contrappesati e due caditoie nella volta di copertura. A
fianco della porta si aprono le gallerie di servizio alle bombardiere a tiro
radente sul piano di campagna - nell'immagine è visibile solo quella di destra. |
 |
L'incrocio dei
tiri delle bombardiere nel punto di congiunzione fra il fianco dei bastioni e le
cortine. Vi sono, per ogni postazione, due scudature in pietra; quelle inferiori
in ottimo stato di conservazione, probabilmente perché coperte fino a tempi
recenti da riporti in terra causati dal vento. Sarebbe opportuno, almeno in
qualche tratto, riportare alla luce il fossato, la cui presenza è denunciata dai
ponti levatoi, oltre che dalla verosimiglianza tipologica. |
 |
A Firenzuola
scavi recenti hanno portato alla luce la base di un'opera esterna "a mezza
corona" dovuta ai Sangallo, estremamente avanzata per l'epoca, e difesa da
bombardiere la cui scudatura è perfettamente analoga a quelle utilizzata nelle
mura di Poggio Imperiale. |
 |
La camera di
manovra delle bombardiere è a pianta trapezia, come di consueto nel
Quattrocento. Nel voltino di copertura si apre un grande condotto a sezione
circolare per lo sfiato dei fumi di sparo, svasato all'imbocco mediante apposito
raccordo in laterizio. |
 |
Ove il
fiancheggiamento dei bastioni adiacenti sembrava insufficiente si sono aggiunte
bombardiere a tiro molto angolato, sempre con la doppia possibilità di tiro,
superiore ed inferiore. La qualità del paramento murario è ovunque di livello
eccellente. |
 |
Sul bastione
della fortezza resta l'innesto della cinta muraria, a doppia rastremazione
superiore per evitare l'approccio al bastione dalle mura della città. Sulla
destra la cannoniera che proteggeva la cortina e, subito sotto, la cornice in
pietra che sembra un gocciolatoio e probabilmente intendeva ostacolare
l'appoggio delle scale d'assedio. |
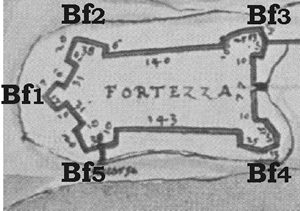 |
La fortezza è
a pianta pentagonale, forse sulla suggestione delle "proporzioni
antropomorfiche" di Francesco di Giorgio Martini. Sulla destra, al centro della
cortina, l'ingresso principale ed a sinistra, sulla punta di Bf1, la pusterla. |
 |
Il vertice del
bastione Bf1 posto all'estremità del saliente verso la campagna è provvisto di
una pusterla sormontata dallo stemma in pietra, secondo la disposizione
riscontrabile nel puntone della rocca di Fossombrone (PU). |
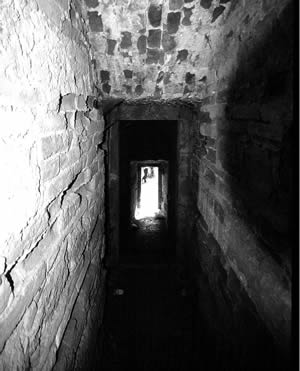 |
La galleria
che conduce alla pusterla di Bf1 è protetta da tre sbarramenti successivi ed è
battuta dal tiro di una postazione soprastante. |
 |
- Le
bombardiere del tratto fianco di Bf2-Bf1-fianco di Bf5 sono inequivocabilmente
"alla francese ibride" per l'unione di una bocca esterna rettangolare a sviluppo
orizzontale e di una camera di manovra interna trapezoidale. Questo tipo di
bombardiere è databile con buona approssimazione alla cerniera fra gli anni
Novanta del XV ed i primi decenni del XVI secolo. |
 |
I bastioni a
lato della cortina d'accesso sono abbastanza inspiegabilmente provvisti di un
diedro aggiuntivo sulla faccia esterna. Sono ben visibili le tre quote di tiro
della fortezza e la predominanza della scarpa sul tratto di paramento verticale. |
 |
Le bombardiere
della fortezza sui tre lati Bf2, Bf3, Bf4 e Bf5, molto prossime al tipo "sangallesco",
sono certamente le più moderne utilizzate a Poggio Imperiale. Notare la
massiccia cornice decorativa in pietra. |
 |
La difesa
sommitale della cortina d'ingresso è affidata ad enormi merloni a spigoli
arrotondati. I pezzi più pesanti potevano tirare tra un merlone e l'altro, altri
pezzi più leggeri nello spessore, mentre la fanteria poteva sparare al di sopra
dei merloni da una piattaforma, servita da due scalette laterali, e dalle
aperture visibili ai lati. |
 |
I pezzi dietro
i merloni erano posti in una inconsueta camera di manovra a pianta
approssimativamente circolare con volta a cupola, che sembra l'interno di un
enorme forno. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|